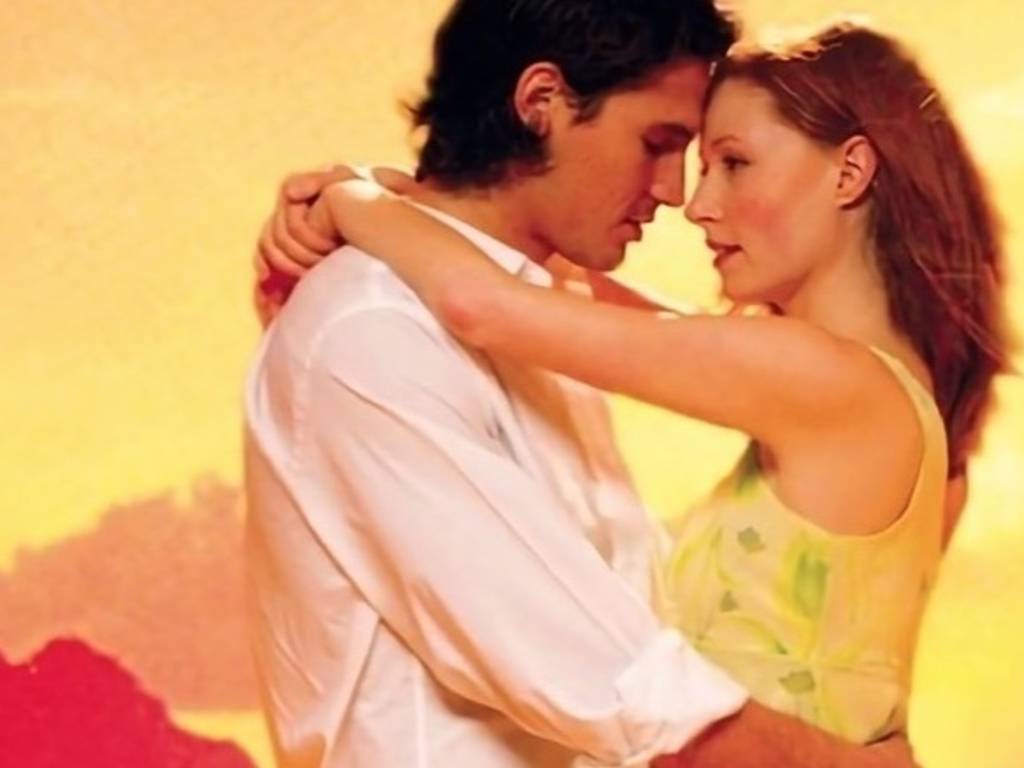Liguria. L’allarme per il virus della peste suina africana (PSA) è stato lanciato dopo che è stato trovato in alcuni cinghiali del Belgio a settembre 2018. Infatti, in Italia è ormai dal 2018 che si effettuano controlli sulle carcasse di suini selvatici (Piano nazionale di sorveglianza passiva). In Liguria nel 2021 sono stati eseguiti test su circa 250 esemplari e nessuno di questi risultava affetto da questa patologia. I primi riscontri positivi sono arrivati dopo un anno rispetto alla partenza dei test, il 6 gennaio 2022 in un cinghiale ritrovato a Ovada e successivamente a Franconalto e Isola del Cantone.
Da sabato scorso, poi, si sono susseguite raccomandazioni e provvedimenti anche da parte della Regione Liguria che, tramite Alisa, ha preso parte all’unità di crisi per far fronte alla questione. I controlli sui campioni spettano all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; in caso di esito positivo il materiale esaminato viene inoltrato al Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine (CEREP) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche per conferma.
L’area infetta individuata dal Ministero della Salute, da Regione Piemonte e Regione Liguria comprende ora complessivamente 114 comuni, 78 in Piemonte e 36 in Liguria; inizialmente riguardava 78 comuni, dei quali 54 in Piemonte e 24 in Liguria all’interno dell’esagono tracciato tra i territori di Genova, Ronco Scrivia, Novi Ligure, Acqui Terme, Spigno Monferrato e Albissola Marina. Le attività vietate sono state riportate in una nota di Alisa: la caccia di qualsiasi specie, la raccolta di funghi e altre attività concernenti le aree boschive, la movimentazione di qualsiasi tipo di animali zootecnici in entrata e in uscita. E’ stata sospesa a tempo indeterminato anche la certificazione veterinaria riguardante l’esportazione delle carni suine.
Il contagio avviene per contatto tra esemplari malati ed è trasmissibile attraverso le movimentazioni di animali, persone, veicoli e materiali contaminati (tra cui rifiuti di cucina, scarpe o vestiti, attrezzi zootecnici. “Vietando queste attività – spiega la dottoressa Monica Dellepiane, dirigente veterinario responsabile della struttura semplice ponente ligure dell’Istituto Zooprofilattico di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta – si riduce la possibilità di diffusione del virus sul territorio e la zona di diffusione rimane circoscritta”.
Prima di oggi, nella nostra penisola questa epidemia era presente solo in Sardegna, ed è endemica dalla fine degli anni ’70. Si sono susseguiti periodi caratterizzati da presenza del virus variabile: dal 2018 è stata registrata l’assenza di focolai nel settore domestico e un numero esiguo di focolai nel selvatico nell’ultimo biennio. “L’obiettivo dell’eradicazione della malattia – è riportato sul sito del ministero della salute – sembra dunque essere vicino”. In Europa la malattia è attualmente diffusa in Polonia, Germania, Estonia, Lettonia, Slovacchia, Grecia, Lituania, Romania, Ungheria, Bulgaria. In Belgio è stata eradicata ufficialmente a novembre 2020, trascorsi 12 mesi senza ulteriori segnalazioni nei selvatici e nessun caso nei domestici.

Questo agente patogeno nella maggior parte dei casi non lascia scampo agli esemplari che aggredisce: “La mortalità si attesta intorno all’80%. Ha una forte resistenza, vive nel materiale organico oltre 18 mesi. Per questo è importante eliminare le carcasse dei cinghiali il prima possibile”, ha spiegato Dellepiane.
Le vittime di questo virus, appartenente alla famiglia Asfarviridae, genere Asfivirus, sono “solo ed esclusivamente – spiega Dellepiane – i suini selvatici e domestici, colpisce tutti gli organi provocando febbre, debilita gli animali e potrebbe provocare emorragie. Sono quindi escluse tutte le altre specie, compreso l’uomo che non corre alcun rischio di contagiarsi”. L’aggettivo “africana” differenzia questo virus da quello della peste suina “classica”, che si presenta leggermente meno grave rispetto a quello riscontrato in questi giorni.
A spaventare e mettere in stato d’allerta sono le ipotetiche ripercussioni economiche che si avrebbero se il contagio si estendesse ai maiali: “Finché rimane circoscritto ai cinghiali la velocità di diffusione è limitata perché vivono in piccoli branchi e, muovendosi in un’areale di pochi chilometri, sono piuttosto territoriali. Se raggiungesse il settore suinicolo danneggerebbe gli allevamenti provocando inevitabilmente danni al commercio”.
In caso di ritrovamento di un cinghiale morto è necessario allertare immediatamente il servizio veterinario competente e non bisogna manipolare la carcassa in alcun modo. “Il virus sopravvive nelle carcasse per lungo tempo e questa prescrizione – ribadisce Dellepiane – ha l’obiettivo di arginare il più possibile la diffusione del contagio togliendo il virus da un ambiente in cui può contagiare altri cinghiali”.
Per capire come è arrivato in Italia e più in particolare in Liguria “sarà necessario procedere con le indagini epidemiologiche”. Secondo le analisi condotte per il momento – si legge sulla pagina del ministero della Salute – “il profilo genetico del virus isolato mostra somiglianza con quello circolante in Europa, mentre è completamente diverso dal virus sardo. Pertanto, al momento, la via di ingresso sembra essere legata prevalentemente alle movimentazioni degli animali selvatici”.
E’ attesa in questi giorni l’ordinanza del ministero della Salute con ulteriori prescrizioni e indicazioni.
leggi anche

Cinghiali morti in Liguria di peste suina africana: Regione raccomanda di non cacciare in questi comuni savonesi